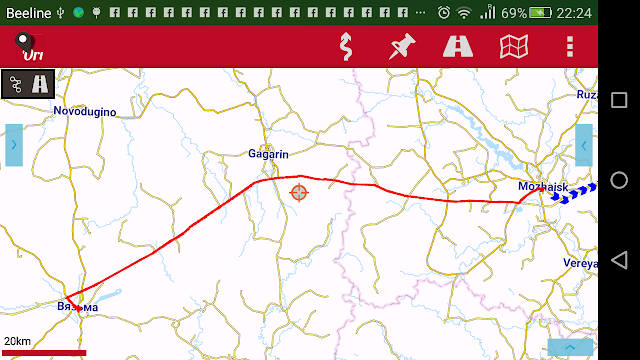Dalla Collina dei passeri si vedono tutta la città, nell’alba
lattiginosa, e il Cremlino.
Finalmente. Da non crederci.
E’ il 14 settembre 1812.
Napoleone si emoziona. Non capitava da anni, forse secoli,
vecchio com’è diventato in quella marcia estenuante verso est.
Finalmente Mosca. Sfaccettata nel prisma delle invisibili
lacrime di gioia, eccola nei suoi colori pastello dell’azzurro e del legno.
I russi se ne sono andati. L’esercito si è ritirato a sud,
in una zona fertile e calma. La popolazione, semplicemente, ha abbandonato le
case e si è spostata nelle campagne orientali. Paura o patriottismo? Ai posteri
l’ardua sentenza.
La Grande armata entra in città senza trovare ostacoli. Non
c’è nessuno.
Le strade sono deserte, vuote le case, i palazzi, le chiese.
Non c’è nessuno.
I soldati si acquartierano, Napoleone si sistema al Cremlino,
dove viveva lo zar. Non c’è nessuno.
Nessuno ad arrendersi, nessuno a chieder pietà e pace all’invasore,
nessuno a sottomettersi al vincitore. Napoleone ha conquistato una manciata di
finestre, di usci, di croci e tegole. Una manciata di vuoto silenzio. Non c’è
nessuno.
Il 16 settembre scoppia un incendio, probabilmente appiccato
dagli stessi moscoviti, che, fra l’altro, fanno sparire ogni mezzo utile a
domar le fiamme. Il fuoco abbraccia i francesi con la sua stretta di morte,
Napoleone deve lasciare il Cremlino. Per due giorni Mosca brucia.
I soldati, nella grandiosa catastrofe, saccheggiano le case,
si ubriacano, dimenticano ordine e disciplina. Nei loro occhi lucidi si
riflettono quei bagliori rossi d’inferno e tutto è caos.
Il 18 Bonaparte torna negli appartamenti dello zar e riesce
a rimettere in riga l’esercito.
Inizia così l’attesa fatale che gli costerà tanto cara. Fino
a metà ottobre l’imperatore tenterà di ottenere dallo zar la resa, prima, e una
pace di compromesso, poi. Ma Alessandro è, con i suoi uomini e la sua gente,
per la resistenza a oltranza contro quel piccolo anticristo venuto da Parigi. Sta
arrivando l’inverno. I mugiki, i contadini, bruciano i propri campi perché non
nutrano il nemico, e, con i partigiani e i cosacchi, conducono una spietata guerriglia
di cascina in fienile, nei boschi e tra i fossi. Sarà Napoleone stesso a
decidere di lasciare Mosca, il 19 ottobre, con tutti i suoi uomini, il seguito
di civili e straccioni e 40.000 carrozze e carretti colmi del bottino raccolto
in città.
Troppo tardi.
Quella ritirata sarà
l’inizio della fine.
30 settembre 1941.
Parte l’operazione Tifone, il capitolo più importante dell’operazione
Barbarossa.
Hitler, come il francese duecento anni prima, vuole il
Cremlino. Vuole Mosca.
Nelle tre settimane precedenti l’esercito del Reich era
riuscito, con una vittoriosa guerra lampo, ad avvicinarsi all’obiettivo.
Ora non resta che conquistare la capitale. Ma arrivano la
pioggia e la neve. Stalin, intanto, schiera 1.500.000 soldati a difesa della
città. 500.000 cittadini si mobilitano e approntano 8.000 kilometri di trincee,
100 kilometri di fossati anticarro e 300 kilometri di reticolati, sbarramenti
di tronchi e barricate. Una ragnatela insuperabile. I non idonei al
combattimento vengono evacuati. Si proclama lo stato d’assedio. La salma di
Lenin viene messa in salvo e Stalin comunica l’intenzione di restare a Mosca ad
affrontare il nemico. I tedeschi falliscono un primo attacco alla città,
protetta dal fango, dal gelo e dal patriottismo disperato dei russi. Gli
assediati festeggiano l’anniversario della Rivoluzione e Stalin esorta alla
resistenza ad oltranza. Fallisce anche il secondo tentativo d’assalto tedesco.
A quaranta gradi sotto zero le armi si inceppano, le dita si irrigidiscono,
congelate, e cadono. I soldati nazisti restano impantanati con i loro carri e
non ricevono più rifornimenti. Fame e freddo mettono in ginocchio le forze
della Wehrmacht.
Il 5 dicembre l’Armata rossa contrattacca. Sull’intero
fronte, con un dispiegamento di un milione e mezzo di soldati. Non ci sono
dubbi. I tedeschi sono costretti alla ritirata. I fanti, mal equipaggiati,
muoiono nella neve come mosche. I carri si bloccano. Le tormente disperdono
interi battaglioni. Un inferno di ghiaccio. La lezione verrà ribadita tra
luglio ’42 e febbraio ’43 a Stalingrado, ma quella è un’altra storia.
Ovvìa, facciamola breve.
Napoleone e Hitler qui non hanno concluso un fico secco.
Io, con tutta la modestia del paragone, sì.
Che il segreto del successo sta tutto nel limare le pretese.
E muoversi d’estate.
Al di là del gongolio spropositato, che è una voluta
esagerazione autoironica, sono proprio felice. Felicissima!
Questi ultimi tre giorni si sono presentati ben più ardui
del previsto.
Un po’ come per le altre due campagne di Russia… Sembrava
ormai fatta, e invece…
Ieri sera sono andata a dormire con ben poche certezze
riguardo alla tappa di oggi. Non avevo più camere d’aria, quelle trovate qui
avevano la valvola incompatibile con il mio cerchione e, peggio del peggio, il
copertone si era sformato e risultava inutilizzabile.
L’unica chance era quella di tornare, per l’ennesima volta,
dal ciclista di Mozhaysk e arrangiare qualcosa, il minimo indispensabile per
questi ultimi 100km. Farsi fermare così a un passo dall’arrivo sarebbe stato
davvero inaccettabile. Piuttosto a piedi trascinando la Signora azzoppata.
Mi sono svegliata presto per tentare ogni via. Ore 6.30
colazione offerta dall’ostello. A scelta: pizza, spaghetti al ragù, trippa e
fagioli, sarciccia. Mentre il barista si è preparato una quattro formaggi (con
pane)
Io ho optato per l’ormai consueto *vusterone, in questo caso
accompagnato da gommosa chioma di spaghetti dell’altroieri, tirati fuori dal
frigo sconditi e nemmen salati. E va be’, sempre carboidrati sono. O
idrocarburi.
Poi via dal ciclista, 23 anni, culo grosso, nome d’arte “Two
wheels”. Ragazzo affabile e assolutamente incapace di metter le mani su una
bici se non per cambiare una camera d’aria o cavolate così. Il suo negozio è un
magazzino vuoto, con accatastati, in un angolo, quattro attrezzi, qualche ciclocancello,
sci del ‘15-’18 e tantissime macchinine a pedali e tricicli e giochi consimili.
Dandogli in mano la ruota montata e con evidente prolasso di
camera d’aria, ha però capito di cosa avessi bisogno. Fatto shopping, ho
armeggiato per lungo tempo per allargare il foro del cerchione, con il
coltello, alla bruttissima. Dai e dai, metallo su metallo, la valvola cicciona
è passata. Da lì è stato tutto un riuscire: a mettere il soviet-kopertone
nuovo, a rimontare la ruota, il raggio che si era staccato (anche) e il
portapacchi tutto ammenciato. Nel giro di un’ora la Signora stava in piedi
sulle sue gomme. Una fina, bella, scorrevole. L’altra grossa, tassellatissima,
pesante. Quasi un cingolo. O un cinghiale. Morto. Da trascinare nel fango
legato dietro alla bici. Ma questo lo avrei sentito bene una volta in sella.
Insomma, cielo grigio nonostante, ero di ottimo umore. Ero
pronta a ripartire. Altro che marcia forzata, altro che treno, altro che taxi.
Io e la Signora on the road again.
E via, mi son rimessa in strada. Oggi c’era poco da
sbagliare: dovevo seguire l’autostrada M1 praticamente fino a 2km prima dell’hotel.
Vogliamo dirlo? Diciamolo: è stato un inferno.
Il vento era fortissimo (anche adesso fa ululare alberi e
lamiere), a raffiche che mi facevano perdere il controllo preciso della bici. La
strada era conciata di buche, gobbe infide dell’asfalto e lavori in corso,
sabbietta e sassi appuntiti. Non c’era quasi mai bordo, e dovevo stare sulla
corsia, con i camion e le auto a 120 a pochi centimetri da me (perché mica si
dan pena di scostarsi, piuttosto ti tagliano la fettina di prosciutto).
In tutto questo, aggiungiamo il grip del copertone che
sembrava incollato all’asfalto.
Per i primi 40km ero così in ansia da non riuscire nemmeno a
controllare la respirazione. Avevo, ad ogni pedalata, l’impressione di aver
forato, presentita nelle lievi oscillazioni e nelle vibrazioni impercettibili, amplificate
dalla paura; il soviet-kopertone è fatto di gomma da masticare e fede nel Sol
dell’Avvenire, temevo il peggio. Benchè tentassi di scacciare questi pensieri,
immaginavo tutti i modi orribili nei quali sarei potuta morire lì sulla strada.
Se il copertone salta mentre sono in discesa a manetta, sulla sabbia, e passa
un tir, vien fuori un art attack di budella. Se il vento mi butta poco poco a
sinistra e sta arrivando un’auto sparata, ciaone. Eccetera. Ero così agitata da
aver le gambe molli e il cuore fuori giri. Oltre ad un fastidioso dolore a
tutta la zampa sinistra, dal piede alla chiappa, spuntato fuori ieri e non
risolto tuttora.
Poi, pian piano, ho preso fiducia nella solidità della
Signora. E’ stata comunque una gran fatica, ma con i pensieri a mare calmo si
può affrontare tutto. E poi c'erano questi cartelli che dicevano chiaramente che le volpi devono proseguire seguendo le alci. Un chiaro segno d'incitamento.
A Kubinka ho incrociato l’enorme museo-campo militare che
raccoglie carri armati delle due guerre mondiali. Non si può visitare se non
previo appuntamento, in quanto parte di una base tuttora operativa… Mi è
spiaciuto.
Così, comunque, ho guadagnato tempo.
Gli ultimi 20km fuori Mosca sono di autostrada vera e propria,
come da noi. E, come da noi, vietatissimi alle bici. Il problema è che le
alternative sono strade peregrine che triplicano il kilometraggio. Sorte per
sorte, l’ho tentata fino alla fine. Mi sono buttata in carreggiata e ho fatto,
quasi trattenendo il fiato, quel pezzettino d’inferno grigio.
Nessuno ha
contestato la mia presenza di ciclovolpe, nemmeno una volante della polizia che
mi è passata accanto. Certo è che, quando sono uscita da quel tratto malefico,
ho tirato un sospiro di sollievo e mangiato una barretta a celebrazione della
sopravvivenza.
A quel punto mancavano circa 30km all’arrivo. Si susseguono
paesini anonimi, inglobati ormai nella mastodontica periferia della capitale,
che han perso confini e identità. La strada, sempre arteria a scorrimento
veloce, corre chiusa nelle pareti antirumore e si attraversa solo con appositi
ponti a scale. Altra roulette russa per il traffico caotico, il vento e il poco
bordo.
Ma l’adrenalina e il desiderio di arrivare all’agognato
cartello che segnava l’ingresso in città mi han spinta su e giù per queste
mostruose cicatrici d’asfalto che rigano la zona a ragnatela.
Ed eccolo. Il cartello. Minuscolo, su incrocio tremendo, ma
inequivocabile. Mosca.
Mosca.
Dopo le foto di rito, perniciosissime a loro volta, la
strada è diventata improvvisamente gentile. I marciapiedi larghi e buoni, le
ciclabili, i sentieri nei parchi. Un inatteso regalo d’accoglienza.
Questo quartiere è un’oasi di pace, tranquillissimo, verde e
pulito, dominato da palazzoni nuovi di dubbio gusto ma comunque piacevoli. Un
altro mondo rispetto al delirio di clacson e polvere, ruderi e case scrostate dei
paesini periurbani.
Sono a breve distanza dalla Collina Plokonnaja, ovvero “degli
inchini” a 10km dalla Piazza Rossa; qui chi arrivava e partiva salutava Mosca con
gesto deferente. Qui Napoleone ha atteso invano le chiavi della città. Qui,
dagli anni Ottanta, sorge l’immenso Parco della Vittoria, che visiterò
domattina prima di muovere verso il centro. Ricorda le vittime delle guerre
patriottiche, soprattutto la seconda.
Per ora mi sono goduta il mini appartamento lussuosissimo,
il cielo bello,
la zuppa ottima e molto moscovita
e la felicità di questa giornata intensa ma
piena di soddisfazioni. Sono arrivata a Mosca, sulle mie zampe, ma per davvero!
Ah, e ho anche fatto il bucato. Che mica si può andare al Cremlino
con le mutande randagie e il calzino buio!